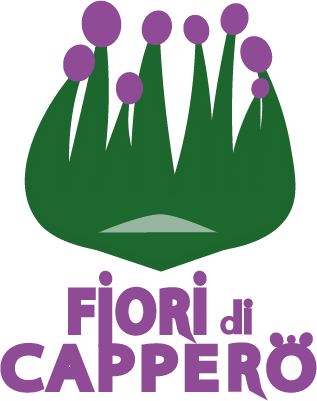Anche se quasi sempre per brevissimi periodi, mi è capitato di fare molti lavori nella mia vita. Sono stato contadino, meccanico di biciclette, cameriere, elettricista, ragazzo delle ripetizioni di latino e di greco, sceneggiatore, regista, produttore, montatore video, fotografo, forex trader, ragazzo delle pulizie, imprenditore di struttura ricettiva, agente immobiliare e pescatore. Sono stato pagato, più o meno regolarmente per aver svolto almeno una volta ognuna di queste mansioni. Più frequentemente, con un buon periodo di preparazione e con un certo metodo mi sono occupato di produzioni video: regia ed editing per video commerciali, tv e documentari. Restano tutt’oggi la mia fonte di guadagno più grande e il codice ateco della mia partita iva mi configura in effetti come lavoratore dello spettacolo. Potrei certamente dire di essere un regista, eppure ogni volta che mi chiedono che mestiere faccio, una parte recondita della mia identità viene risucchiata da un vortice di paura. Forse sono solo le debolezze annoiate di un uomo benestante. Gran parte di quello che ho potuto fare, in effetti, mi è stato concesso dalla facoltosa lungimiranza della mia famiglia, che ha mantenuto i miei studi e, finché lo hanno ritenuto opportuno, anche le mie cazzate. Tuttavia, benché ne stia parlando in termini del tutto personali, sono convinto che “lavoro” ed “identità”, in relazione l’uno con l’altro (ammesso che esista ancora questa relazione), costituiscano uno dei binomi filosofici del millennio, per la portata culturale, sociale ed economica che detengono e, per questo motivo, mi fa piacere approfondirli.
Italo Calvino, nella sua introduzione alla raccolta poetica “Lavorare stanca” di Cesare Pavese, interpreta così il significato del titolo:
“Il titolo Lavorare stanca sarà appunto la versione pavesiana dell’antitesi (…), ma senza gaiezza, con lo struggimento di chi non si integra: ragazzo nel mondo degli adulti, senza mestiere nel mondo di chi lavora, senza donna nel mondo dell’amore e delle famiglie, senza armi nel mondo delle lotte politiche cruente e dei doveri civili”.
Personalmente penso che la poetica pavesiana, descritta da Calvino, che è una condizione esistenziale prima ancora di essere una visione poetica, oggi diviene tematicamente attualissima. Certo, per Pavese, vissuto nella voragine della seconda guerra mondiale, il dualismo era tra le altre cose politico, tra il prendere parte e il nascondersi. Eppure io credo che oggi, pur non vivendo da vicino il dramma della guerra mondiale (almeno per ora!), abbiamo comunque una vita spaccata in due tra l’essere e l’avere, tra il volere e il potere, tra l’essere se stessi e l’apparire. È un dualismo che anche oggi non è integrato e spesso crea enormi disagi esistenziali.
Partiamo da un considerazione filosofica alla base di questa ostica dissertazione. Uno dei motti con il quale è passato alla storia il filosofo empirista Berkley è “esse est percipui” (“essere significa essere percepiti”).
Nell’antichità e per buona parte dell’alto medioevo, il lavoro era espressione di una rigida gerarchia sociale. Le comunità umane erano governate da poteri universali che, in cambio di protezione, distribuzione delle ricchezze e gestione pubblica, esercitavano il potere in maniera pressoché assoluta, cioè con la forza militare e con il volere di Dio. Il lavoro ed il destino di ogni individuo erano spesso decisi prima della propria nascita.
In definitiva, si faceva ciò che si era.
A partire dall’alto medioevo, poi, il potere non più accentratore aveva reso possibile lo sviluppo del libero commercio e della libera iniziativa personale. Il lavoro iniziava a rendere ricche le persone, anche quelle non nate già ricche e, per questo motivo, alcuni lavori divengono rivincita e simbolo di riconoscimento sociale dell’individuo.
Vengono rovesciati i termini del binomio identità-lavoro.
Non si fa ciò che si è, ma si è ciò che si fa.
“Homo faber fortunae suae” diviene poi il precetto umanista. Il lavoro non era più solo un modo per perpetrare la propria esistenza, ma diviene anche un modo per cambiare il proprio destino. Ci si convince che un buon mestiere può cambiare le sorti di chi lo fa bene e anche quelle della sua stirpe. In un periodo di rivoluzione delle conoscenze (la scoperta dell’America, l’invenzione della stampa, lo scisma luterano e la teoria Copernicana), l’uomo riscopre il valore della sua libertà ed è proprio la diffusione di questo nuovo convincimento, la radice da cui è cresciuta la pianta del capitalismo. Max Weber, uno dei padri della sociologia moderna, associa l’abnegazione per il lavoro ad un concetto che si diffonde proprio in questo periodo con l’avvento della religione protestante a seguito della predicazione di Lutero. Si tratta del concetto religioso del Beruf, letteralmente “la chiamata”. L’idea è questa: ciò che uno fa in vita è ciò che è stato chiamato a fare da Dio, quindi è conveniente e moralmente giusto farlo al meglio per onorare la sua chiamata. Per Weber questa ideologia è il substrato culturale che ha portato allo sviluppo del capitalismo. Lo spirito imprenditoriale risponde alla chiamata di Dio. A tale proposito scrive Weber ne “L’etica protestante e lo sviluppo del capitalismo”:
“Incondizionatamente nuova era comunque una cosa, in primo luogo: la convinzione che l’adempimento del proprio dovere nell’ambito delle professioni mondane fosse il contenuto supremo che potesse mai assumere la realizzazione della propria persona morale”.
Si dovranno aspettare circa quattro secoli perché i termini del binomio identità-lavoro vengano ulteriormente ribaltati. Con la rivoluzione industriale e le guerre di colonialismo, il mondo intero viene investito dall’avvento della globalizzazione. D’improvviso il lavoro diviene una componente del mercato, soggetto a costi, inflazione e concorrenza. Non basta più saper far bene un mestiere ed avere lo spirito imprenditoriale giusto per arricchirsi. Quello che conta è la grandezza del capitale da poter investire e il posizionamento sul mercato. Chi ha in mano i meccanismi di produzione e della distribuzione, diviene spropositatamente ricco. La ricchezza se viene reinvestita produce altra ricchezza e crea monopolio, in un ciclo senza fine che ancora oggi si perpetua. C’è chi, addirittura, ha visto le guerre mondiali come un prodotto di questo sistema globalizzato. Forse una esagerazione. Sta di fatto che questo processo ha creato due nuove figure antitetiche (Hegel dixit) di lavoratori: l’imprenditore, il cui mestiere è creare profitto (e non più solo beni o servizi) e l’operaio il cui mestiere è produrre merce per chi lo paga, senza rivestire più nessun ruolo sociale. Quest’ultimo mestiere fa perdere al lavoratore la libertà decisionale, reificando la sua identità. Karl Marx conia l’espressione di alienazione del lavoratore, partendo proprio dalle condizioni di lavoro degli operai delle fabbriche, i quali producevano cose che non gli appartenevano, impiegando tempo e salute che, anche queste, non gli appartenevano perché pagate dall’imprenditore e, in definitiva, non possedevano neanche più la loro stessa anima.
Scrive Marx ne “I manoscritti economico filosofici del 1844”:
“La svalorizzazione del mondo umano cresce in rapporto diretto con la valorizzazione del mondo delle cose. Il lavoro non produce soltanto merci; produce se stesso e l’operaio come una merce, e proprio nella stessa proporzione in cui produce in generale le merci”.
L’equazione identità-lavoro viene nuovamente ribaltata: faccio, quindi non sono.
Questa mancanza di identità, non crea solo alienazione, crea anche paura. Paura di perdere soldi, di farsi fregare il posto da qualcun altro che si accontenta di meno e lavora di più, paura del mondo. A proposito di questo sentimento, risultato abbietto del mondo capitalista, mi viene in mente una battuta di quello straordinario romanzo di Steinbeck che è “uomini e topi”. Il vecchio del rench sorprendendosi di vedere una coppia di ragazzi presentarsi a lavorare dice:
“Non ce ne sono molti che vanno in giro a lavorare in coppia” scherzò. “Non so perché. Forse in questo dannato mondo ognuno ha paura dell’altro”.
Dove ci ha portato questa paura? Cosa sta succedendo oggi? Perché si fa fatica a riconoscersi socialmente nel proprio mestiere?
Con l’avvento della borsa e di internet, i mercati globali hanno intrecciato fra di loro una fitta relazione di interdipendenza e di conseguenza si è globalizzato anche il capitale. Non solo. La stessa sorte è spettata al consumo: le multinazionali hanno abbattuto le barriere culturali e linguistiche, rendendo universale il valore delle merci che vendono. Questo imperialismo, che Marx aveva già previsto, ha annientato il ruolo sociale del lavoro che è rimasto ancorato alle condizioni politiche locali di ogni singolo paese produttore-consumatore. Ecco dunque che se un bene di consumo ha valore universale in tutte le parti del mondo, il lavoro di chi ha contribuito alla realizzazione di quel bene, invece, ha un valore molto relativo e spesso molto più basso del prodotto stesso. Non basta. È completamente saltato il ruolo sociale del lavoro. Un medico spesso guadagna migliaia di euro in meno di un dj, un contadino molto meno di un influencer. Ciò che si produce non è solo svuotato del suo valore intrinseco, ma anche di quello estrinseco. Il valore sociale è svincolato dalla società, tanto tutto si può comprare in fondo e quindi è solo il mercato a decidere cosa serve di più. Essenzialmente quello che serve è solamente quello che vende di più. E infine, come se non bastasse, c’è la digitalizzazione. L’impiego massiccio della tecnologia nei processi produttivi e l’utilizzo dei social come mezzo di pubblicità hanno eliminato la corporalità e la temporalità delle merci, rendendo qualsiasi prodotto sempre e ovunque disponibile e allontanando il consumatore dalla problematicità di mantenere questa disponibilità eterna (senza tempo e senza spazio). Il risultato è quindi quello di fare tutti lo stesso mestiere: consumare. Non c’è altro da fare. Non c’è un mestiere che spieghi meglio quello che facciamo tutti. Il superfluo ormai è necessario e l’acquisto diviene l’unica cifra identitaria con la quale ci misuriamo sempre.
Compro, quindi sono.
Per essere, quindi, servono soldi. Ne servono tanti e subito, non importa come vengono fatti, importa averli per godersi la vita e soprattutto per rappresentarsi. Per identificarsi in qualcosa.
È una di quelle verità non dette che mi fa venire le vertigini ogni volta che la sento realizzata. Succede spessissimo di venire giudicati o di giudicare in base a quello che acquistiamo, o peggio in base a quello che possiamo permetterci di acquistare. Le scelte di vita, oggi, si fanno quasi sempre in base alle scelte di acquisto. L’impressione è quella di essere rimasti intrappolati nella tela di un ragno a cui ogni giorno diamo da mangiare. I diritti, la dignità e il ruolo sociale sono del tutto irrilevanti nel consumo globale. E quindi cosa succede? Succede che, il lavoro ha perso gran parte del suo fascino etico; serve solo un modo veloce, disperato e spregiudicato di fare soldi. Chi lavora tanto e bene, a meno che non guadagni benissimo, è considerato solo un ingenuo coglione che sta perdendo il suo tempo. I licenziamenti di massa e la carenza di personale nei settori manuali o con poco margine di guadagno sono la prova che il lavoro non è più inteso come ruolo, ma unicamente come mezzo per sostenere il consumo. Ed è qui che entra in gioco il web e le sue vie alternative. Oggi, è boom di influencer, onlyfanser, re-buyer, airbnb host, crypto trader, ma anche data analyst, big data specialist, cyber security manager, AI developer e così via. Ci metto anche il mestiere del videomaker che è quello che faccio. Sono i cosidetti nuovi mestieri, che in qualche modo hanno bisogno di essere spiegati, perché mancano di quel riconoscimento sociale che non è più nella comunità degli uomini, ma è nella comunità dei dati, degli algoritmi, dei soldi. Il lavoro è prima di tutto indipendenza economica ed escamotage pecuniario. Non importa se per raggiungerlo si debba passare la propria vita davanti ad un computer, ci si debba riprendere in mutande nella neve, o riscoprire rivenditori di airpods cinesi; non importa se ci si debba filmare mentre si ingurgita più cibo possibile o si debba streammare per un mese intero, giocando a Fortnite. Non importa che lavoro facciamo, importa solo quanto guadagniamo e quanto tempo libero possiamo passare a consumare. Certo, la perdita del riconoscimento sociale del lavoro lascia più libertà d’azione, ma al tempo stesso, avvilisce la propria vita.
Quindi se da un lato c’è meno retorica, dall’altra c’è meno dignità.
Le mie sono considerazioni tendenziali e non bisogna, per questo motivo, generalizzare: chi svolge con felicità e soddisfazione il proprio lavoro, qualunque esso sia, è senza dubbio una persona da stimare. Una dimensione lavorativa nella quale si è in grado di mantenere un equilibrio tra guadagno e ruolo sociale, tra fare ed essere è senza dubbio ancora possibile, ma sembra sempre più raro e complicato. La premessa a questi miei ragionamenti, infatti, partiva dalla considerazione che, pur avendo fatto tanti lavori, non sono ancora stato in grado di trovare questo equilibrio. Certo il demone che mi porto dentro della narrazione non mi aiuta a sentirmi una persona equilibrata. Per parte mia, a volte penso che potrei essere contento di fare il guardiano di un faro per potermi dedicare totalmente alla scrittura, salvo poi riflettere che mi annoierei a morte. Comunque per i pochi che ancora lavorano avendo la convinzione del valore di ciò che fanno, forse rimane ancora viva una fiaccola che ha sempre reso felice l’essere umano: la passione.
Ma essere innamorati del proprio mestiere è davvero l’unica cosa che può salvarci? O saremo comunque destinati ad essere soltanto dei consumatori felici di fare qualcosa che qualcuno è disposto a pagare?
Provo a cercare la risposta a questo dubbio, nell’apocalisse della poetica di uno scrittore la cui salvezza ci ha resi uomini migliori. Ecco le parole di Primo Levi:
“I salvati del Lager non erano i migliori, i predestinati al bene, i latori di un messaggio: quanto io avevo visto e vissuto dimostrava l’esatto contrario. Sopravvivevano di preferenza i peggiori, gli egoisti, i violenti, gli insensibili, i collaboratori della “zona grigia”, le spie. Non era una regola certa (non c’erano, né ci sono nelle cose umane, regole certe), ma era pure una regola. Mi sentivo sì innocente, ma intruppato tra i salvati, e perciò alla ricerca permanente di una giustificazione, davanti agli occhi miei e degli altri. Sopravvivevano i peggiori, cioè i più adatti; i migliori sono morti tutti”.